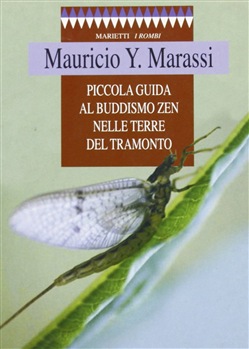L’avvento del buddismo in India circa 2500 anni fa, come leggo dal libretto La pratica dello zazen, edito dalla comunità buddista italiana La Stella del Mattino, ha la sua radice nella civiltà e nella letteratura religiosa vedica, in cui non si riscontra alcuna riflessione sulla ‘sofferenza’ nel mondo o sul ciclo delle rinascite, quanto piuttosto nel godimento (bhukti) della vita terrena.
Ma nella predicazione del Buddha non troviamo neppure accennata una dottrina della rinascita.
La questione del nascere e del morire si presenta solo parecchi secoli dopo. Scrive Mauricio Yushin Marassi:” Il motivo è legato al pragmatismo buddista: se consideriamo che all’interno del buddismo il problema è “solo” per così dire, la dissoluzione della sofferenza del vivere e del morire, non ha particolare importanza se le condizioni di nascita in questa vita siano determinate dal karman accumulato nella vite precedenti oppure no”. Inoltre, Buddha non sostiene che esista un’anima individuale (atman) di natura eterna, quindi “la credenza nelle rinascite può essere messa da parte..”.
Il significato del nascere e del morire assume nel buddismo zen un significato diverso che nella cultura Occidentale. Il binomio vita/morte nella pratica si risolve in una vita pronta alla morte. La finitudine temporale del vivere diventa vita per la morte solo se accompagnata da un percorso di consapevolezza e di liberazione dalla sofferenza che ci rende in grado di vivere nella pratica “una vita pronta alla morte” o, come scrive Marassi, una vita “nella quale la morte non ha più nulla da togliere, se non il corpo, ultimo legame con il mondo dei vivi”. Vediamo di chiarire, seguendo il ragionamento di Marassi.
La liberazione dalla sofferenza per un buddista non è, banalmente, evitare il dolore, a volte inevitabile.
E’ invece un processo di sviluppo interiore che può essere compiuto da due punti di vista: le modalità pratiche di questo cammino; il significato che per lo spirito assumono quel nascere e morire, che ogni vivente è destinato a sperimentare.
La pratica, in giapponese, è detta zazen, letteralmente “sedersi sullo zen”. Conosciamo la postura: sul pavimento, seduti su un cuscino, le gambe incrociate, la schiena dritta, i piedi sulle cosce, di fronte ad una parete, in perfetto silenzio, luce e temperatura confortevoli. Una pratica millenaria che, secondo Marassi:” è la forma nella quale il corpo diviene un tempio all’interno del quale è possibile edificare la liberazione dalla sofferenza connessa alla finitudine dell’uomo”.
Scrive Marassi: “.. non c’è nulla da toccare, da udire, da odorare, da vedere, da assaporare, i cinque sensi sono privi di oggetto.”
Ma quello che importa qui è la forma interiore del praticare lo zezen, o meglio i suoi effetti. La postura interiore è quella del lasciare, del “cessare di afferrare” ricordi, emozioni, speranze, desideri, progetti e valutazioni sul bene e sul male, sulle nostre come sulle altrui azioni.
L’obiettivo è quello di impedire il sorgere dei pensieri. Lo zazen consiste nella pratica del “non afferrare” del “lasciare” i tanti pensieri che si affacciano alla mente durante la meditazione e nello “svegliarsi” da qualunque “illusione le mente costruisca, comprese le elaborazioni metafisiche”. Il buddismo, infatti, non è una metafisica, né un tentativo di stabilire “come stiano le cose”: è “solo” la via che conduce alla liberazione dalla sofferenza”
La pratica della meditazione zazen comporta, in definitiva, che ciò che naturalmente insorge con continuità nella nostra mente si trasforma in un continuo “cessare”. “Da una parte c’è la nostra vita, i legami familiari, quelli con la comunità, le speranze e i sogni, l’amore per la vita, il timore della malattia e della morte”, dall’altro tutto ciò non c’è. Rinunciare a tutto ciò che chiamiamo “vivere”, staccarsene senza rimpianti, vuole dire morire. “…Ci troviamo in una terra di nessuno, un “dove” infinito nel quale vita e morte si incontrano e si invertono, si scambiano i ruoli”.
In conclusione: “Ogni volta che facciamo questo, ossia ogni volta che nasciamo, viviamo e consensualmente moriamo, non scompariamo nel nulla, non c’è l’annullamento totale in quanto la pratica buddista “..ha le caratteristiche di una morte in vita: quello che dal punto di vista del mondo è “morte”, abbandono, scomparsa, visto dall’interno della pratica diviene una continua “nascita”.
Nel Dhanmapada (Cammino religioso) è scritto: “Vedi il mondo come insostanziale, fugace, una bolla, illusorio, un semplice miraggio: il re della morte non riuscirà a scovarti”.
Mauricio Yūshin Marassi nato a Buenos Aires nel 1950, pratica e studia il buddismo.
Dal 2009 è direttore responsabile della Stella del Mattino, Comunità buddista zen italiana. Dal 2003 è professore a contratto presso l’Università Carlo Bo di Urbino dove attualmente tiene un corso sulla cultura del dialogo interreligioso.